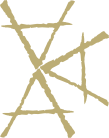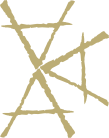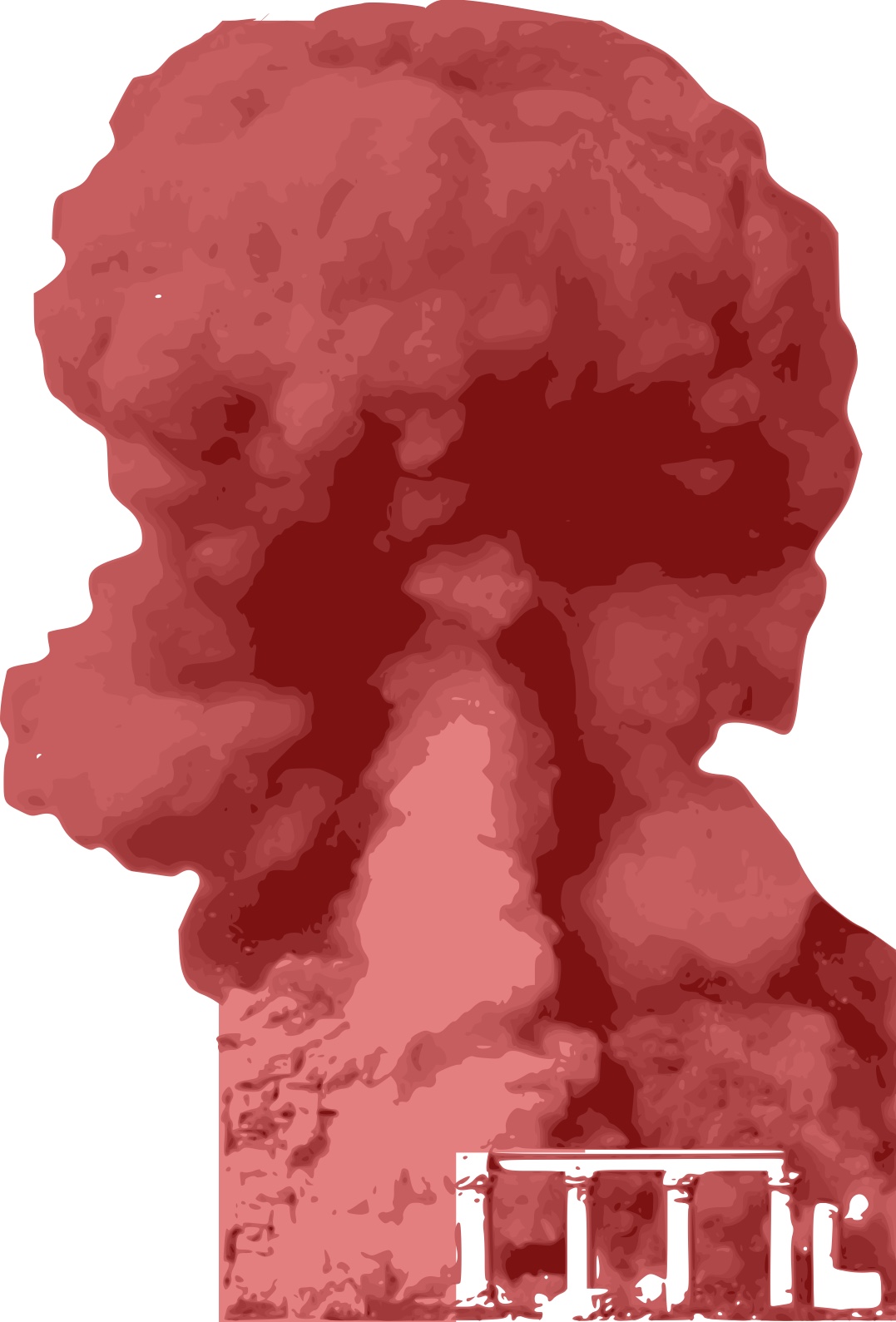Abbiamo aggiornato le nostre politiche sulla privacy, con questo aggiornamento ci atteniamo alle rigide normative stabilite dal regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).
Per continuare a usufruire dei nostri servizi è necessario che tu proceda all’aggiornamento dei tuoi dati accettando la nuova privacy policy
Grazie